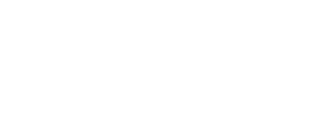IL PROGETTO
Questo calendario è un piccolo viaggio attraverso le “mode”, tradizionali e non, dell’Africa di ieri e di oggi, che aggiunge un altro tassello alla conoscenza del continente.
Si dice che l’abito non fa il monaco, ma non è del tutto vero. L’abito è una seconda pelle, che noi umani usiamo non solo per coprire i nostri corpi – nei climi caldi sarebbe inutile – ma anche e soprattutto per dire chi siamo.
Non a caso usiamo il termine “costume” per indicare anche le caratteristiche culturali di un popolo.
I tessuti, i colori, la foggia dicono molto della cultura cui si appartiene e l’Africa non fa eccezione. Al contrario, la ricchezza culturale, la ricca galassia etnica di questo continente ci offre un panorama vasto e variegato. Legato al clima, certo, ma non solo, alcuni abiti raccontano storie venute da lontano, come nel caso degli Herero della Namibia, altri esprimono mode urbane più recenti, come quella dei Sapeur di Kinshasa, altri ancora sono divenuti una sorta di marchio “etnico”, pensiamo al velo dei Tuareg. Per non parlare degli abiti disegnati sul corpo o del non abito di certi specialisti religiosi.
LA COLLABORAZIONE
Phoebe Ouma
 Cresciuta nella periferia di Nairobi, si è trasferita in Iowa quando aveva quattro anni ed è tornata in Kenya quando ne aveva dieci. Ora risiede a Nairobi a tempo pieno.
Cresciuta nella periferia di Nairobi, si è trasferita in Iowa quando aveva quattro anni ed è tornata in Kenya quando ne aveva dieci. Ora risiede a Nairobi a tempo pieno.
È cresciuta senza vedere molte persone che le assomigliavano sulle riviste ed è determinata a fornire una prospettiva diversa alle donne di colore.
Il suo lavoro è stato pubblicato sul Nation Newspaper, sulla CNN, sulla rivista Precision Air In-flight e su Die Presse.
Marco Aime
 Antropologo culturale e saggista italiano laureatosi nel 1988 presso l’Università di Torino, dal 1999 ricercatore presso l’ateneo di Genova dove dal 2000 è docente di Antropologia culturale, ha condotto indagini sul campo in vari Paesi dell’Africa occidentale, indagando trasversalmente il tema del viaggio che, insieme a quello della differenza e dell’identità, costituisce l’infrastruttura epistemologica delle sue ricerche.
Antropologo culturale e saggista italiano laureatosi nel 1988 presso l’Università di Torino, dal 1999 ricercatore presso l’ateneo di Genova dove dal 2000 è docente di Antropologia culturale, ha condotto indagini sul campo in vari Paesi dell’Africa occidentale, indagando trasversalmente il tema del viaggio che, insieme a quello della differenza e dell’identità, costituisce l’infrastruttura epistemologica delle sue ricerche.
TUAREG
GENNAIO

L’abbigliamento Tuareg, gruppo etnico nomade che abita le zone del Nordafrica, è caratterizzato dall’uso del tagelmust, lungo velo indaco che funge da copricapo, dalla tradizionale leggerezza e colore che spesso contamina la pelle dei loro visi. Dal modo in cui viene indossato si possono evincere molte informazioni: dallo status sociale fino al suo stato d’animo. Per esempio, durante il primo sollevamento Tuareg in Mali, nel 1963, veniva annodato vistosamente al collo, come provocazione alla pratica delle impiccagioni di massa perpetrate dall’esercito maliano. Abito come riparo dal sole e dal vento, ma anche come linguaggio, che esprime carattere e storia di chi lo porta.
HERERO
FEBBRAIO

«Il cacciatore indossa la pelle dell’animale che ha ucciso» recita un proverbio africano. Gli Herero della Namibia sembrano avere piegato queste parole alla loro storia.
Gli abiti che le donne indossano, ricordano quelli delle dame tedesche dei primi del Novecento, quando il Paese, che allora si chiamava Africa del sud-ovest, era governato dai Tedeschi. Tra il 1904 e il 1908, per mano del generale Lothar von Trotha venne perpetuato un vero genocidio ai danni di questo popolo. Si calcola che siano state almeno 80 mila le vittime. Paradossalmente, da allora indossare quegli abiti, significa ricordare quella tragedia, ma allo stesso tempo celebrare il fatto di essere ancora vivi.
SAPEUR
MARZO

«Société des Ambianceurs et des Personnes Elégantes», in breve SAPE, per gli abitanti di Brazzaville e di Kinshasa. Nato all’inizio del Novecento nella capitale del Congo francese, questa sorta di movimento raccoglie giovani che amano apparire raffinati, di un’eleganza che si traduce in uno stile di vita. Nato nelle classi sociali medio-basse in cerca di un’identità, questo movimento è cresciuto tanto in relazione quanto in opposizione al colonialismo: ispirarsi al modello europeo di abbigliarsi, ma con criteri africani, seguendo abbinamenti di colori e capi, lontani dai modelli originali. Con il passare del tempo, la Sape si è trasformata in un movimento culturale, con codici e ritualità ben definiti. Questi dandy africani frequentano circoli o caffè culturali nei quali si parla di donne, musica e letteratura. La Sape è un tipico esempio di sincretismo, in cui apporti diversi si fondono in un insieme nuovo.
KENTE
APRILE

Associato alla ricchezza, all’elevato status sociale e alla raffinatezza culturale, il tessuto Kente del Ghana è probabilmente il tessuto più significativo e stimato in Africa.
Il nome deriva dalla parola kenten che significa «cestino» poiché, in origine, il tessuto era costruito con fibra ricavata dalle fronde di palma. Il centro del mondo Kente è una piccola città del Ghana chiamata Bonwire, in cui la produzione tessile risale al 1000 d.C. e affonda le sue radici in una tradizione risalente al 3000 a.C. circa. Originariamente era il «panno dei re», ma oggi è diventato quanto mai di moda. Non più tessuto, ma stampato, il Kente
ed è utilizzato da molti stilisti contemporanei, che ne rivisitano le trame tradizionali in chiave moderna, dando vita a uno stile quanto mai originale.
ALPHADI
MAGGIO

Nato a Timbuktu da una famiglia di lignaggio nobile Tuareg, Sidahmed Seidnaly, detto Alphadi, è noto come il «mago del deserto». Il suo stile originale è basato sulla fusione tra il sapere ancestrale dei gruppi etnici del Sahel (Songhai, Hausa, Fulani, Bambara, Arabo), culture nomadi dell’Africa Orientale (Bororo, Masai) e reinterpretazioni creative del design occidentale. Nel 1998 ha fondato il Festival International de la Mode Africaine, sostenuto dall’Unesco, che gli ha conferito il titolo di Ambasciatore di buona volontà, per il suo impegno nella cultura e nello sviluppo al servizio della pace, del rispetto e della dignità umana, e per il suo contributo alla promozione della tolleranza. Lo stile di Alphadi attinge a culture e pratiche provenienti da tutto il continente. Caratteristica comune alle sue creazioni è il tessuto kuba, originario dell’antico regno Kuba dell’Africa centrale, realizzato con rafia intrecciata. L’intricata decorazione viene ottenuta attraverso ricami a pelo tagliato. I disegni vengono cuciti sul tessuto, quindi la fibra di rafia viene infilata con un ago e tagliata con un coltello per formare un pelo denso, creando un effetto morbido, simile al velluto.
OUMOU SY
GIUGNO

La moda africana è uscita dall’Africa, per affermarsi in tutto il mondo, grazie a stiliste e stilisti di grande fama, come Oumou Sy, senegalese, impegnata in una ricerca caratterizzata dalla contaminazione fra arte, spettacolo e vita sociale. Infatti, da anni promuove un’assidua collaborazione con altri artisti africani impegnati in diversi media, quali il cinema, il teatro, la musica e la danza, per fare acquisire ai suoi abiti la stessa dignità delle altre arti “maggiori”. Ha disegnato abiti per dei film e ha vestito cantanti famosi, tra tutti Youssou N’Dour.
Le sue creazioni sono caratterizzate da copricapi adornati con piccole zucche o CD, sono decorate con piume, conchiglie, bacche, liane, seta raso vetro. Una «rivisitazione» dei più grandi stilisti europei con una creatività che non conosce limiti e un’ironia spesso trasgressiva. Oumou Sy è un simbolo dell’Africa di oggi, piena di fervore, sospesa tra passato e futuro. I suoi disegni fanno parte della collezione permanente del Museum of Black Civilizations a Dakar.
MITUMBA
LUGLIO

Mitumba è un termine swahili usato per indicare balle, dai 40 ai 50 chili, contenenti vestiti usati, prevalentemente donati, provenienti dai Paesi occidentali. Quante volte, viaggiando in Africa, si incontrano bambini e ragazzi con indosso magliette o camicie occidentali o vecchie maglie di squadre di calcio. Il termine si applica anche ai vestiti che arrivano in questi pacchi. Uno dei principali porti di ricezione di Mitumba è la città tanzaniana di Dar es Salaam. Da lì gli indumenti si disperdono ampiamente nell’interno dell’Africa. Il trasporto e la vendita di Mitumba sono responsabili di molti posti di lavoro sia nelle ricche aziende donatrici che nei paesi africani dove vengono acquistati e venduti. I critici osservano che l’afflusso di abbigliamento a buon mercato è responsabile del declino delle industrie tessili locali. I sostenitori sottolineano che l’abbigliamento è vantaggioso in quanto stimola l’attività economica e consente alle persone con mezzi limitati di permettersi abiti alla moda.
IL NON ABITO
SETTEMBRE

I sacerdoti Taneka, piccola popolazione che vive nel Benin settentrionale, quasi non indossano abiti, tranne un piccolo perizoma. «L’abito è arrivato con l’islam» dicono e poiché loro sono i discendenti dei fondatori dei villaggi, rappresentano gli antenati e ne conservano il comportamento. Infatti, oltre a non indossare abiti, mangiano solo cibo tradizionale, cucinato in pentole di terracotta e non di metallo e seguono comportamenti rituali, legati al passato. Sono i veri depositari della tradizione locale. In questo caso è la mancanza d’abito e fare sì che questi personaggi, si distinguano dalla gente comune. L’abito, tra i Taneka, non fa il monaco, anzi…
BOGOLAN
SETTEMBRE

Bogolan in lingua bambara significa «di terra». Lavorato al telaio, il tessuto viene poi immerso in un decotto di foglie di betulla africana, per poi essere lavorato nel fango. È proprio il colore della terra, infatti, a caratterizzare questo tessuto che, secondo le antiche leggende, possiede particolari poteri protettivi. Non a caso, all’inizio erano solo i donsow, cacciatori e guaritori di etnia mande, a indossare abiti di questo tessuto, che possedevano un potere protettivo, e mettevano al riparo sia dai pericoli materiali della caccia, sia da quelli del mondo spirituale. Anche le donne sfruttavano il potere mistico del bogolan, dopo aver partorito. Oggi questo tessuto «arcaico» è diventato di moda e lo si trova in negozi di moda etnica in Europa e negli Stati Uniti, utilizzato tanto per confezionare abiti, quanto per l’arredamento.
L’ABITO DIPINTO
OTTOBRE

Tanto tra i Karo quanto tra i Mursi dell’Etiopia meridionale, il corpo maschile diventa una sorta di tela pronta per essere dipinta. Gli uomini di queste due etnie si vestono di disegni, realizzati sulla pelle con il caolino, che assumono forme decorative caratteristiche. La nudità viene così annullata dal disegno, che è abito, ma anche opera rituale: i disegni, infatti, rievocano la pelle del leopardo, le piume della faraona selvatica o altri animali. Come sempre le contaminazioni culturali inducono a dei cambiamenti e non è raro oggi incontrare giovani karo o mursi con disegnati sul corpo dei pantaloncini corti o una maglia da calciatore. Una forma di arte, dunque, ma di arte effimera, destinata a scomparire a ogni lavaggio, per essere rifatta in un perenne ciclo di rigenerazione.
MASAI
NOVEMBRE

Siamo abituati a pensare i Masai avvolti nello Shuka, l’abito tradizionale di colore rosso che avvolge il corpo delle donne e degli uomini. In realtà, prima dell’arrivo dei coloni, vestivano con abiti di pelle bovina, tinti con colori vegetali, così come i gioielli erano fatti di semi e pietre. Fu con l’arrivo degli Europei che cominciarono a sostituire le pelli di vitello o di pecora con teli di lana o cotone e le perline vegetali con quelle di vetro portate dall’Europa. I colori sono indice dello status di chi li porta, ma esprimono anche concetti simbolici: i giovani vestono di nero per i mesi successivi al rito della circoncisione, poi si passa al rosso, che si dice avere il potere di tenere lontane le bestie feroci. Il blu è il colore del cielo e della pioggia, che disseta le mandrie e gli esseri umani ed evoca quindi la vita, mentre il bianco rappresenta la forza, essendo il colore del latte.
NDEBELE
DICEMBRE

I primi viaggiatori che arrivarono nei villaggi Ndebele, in Sudafrica, rimasero colpiti dal colore delle case, degli abiti e dai numerosi ornamenti che indossavano le donne. In particolare, gli anelli portati attorno alle braccia, alle gambe e al collo dalle donne. Questi anelli, oltre a essere considerati strumenti di bellezza, simboleggiavano lo status della donna: le ragazze in età da matrimonio, dopo la cerimonia di iniziazione, indossavano anelli di erba intrecciata e ricoperti di perline, attorno al collo e alle braccia, chiamati isigolwani. Le donne sposate, invece, indossavano monili di rame e ottone, segno visibile del legame con il marito e la fedeltà allo stesso. Tali anelli venivano rimossi e abbandonati in caso di morte del marito. Il numero di anelli indicava anche la ricchezza dell’uomo: più ricco era il marito, più anelli la moglie avrebbe indossato. La nascita del primo figlio veniva celebrata indossando uno speciale grembiule, chiamato ijogolo, dalla forma di una mano con le cinque dita rivolte verso il basso. Oggi la tradizione di indossare gli anelli non è più una pratica comune, ma rivive in occasione di cerimonie speciali.